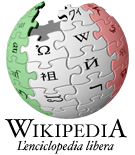di Antonio Padellaro
È destinato a cambiare il corso della politica italiana l’allarme lanciato da Romano Prodi sul rischio di una «moderna e pericolosissima dittatura della maggioranza e del suo premier». Diretta conseguenza, ha detto il leader dell’Unione, della riforma della Costituzione imposta dalla Casa delle libertà, «che crea un rischio grave e imminente per la nostra convivenza democratica e contro cui il centrosinistra si batterà in ogni modo». Cambia la politica che abbiamo conosciuto fino a ieri, perché fino a ieri nessun capo dell’opposizione si era espresso in termini tanto drammatici nei confronti di questo «assalto alle istituzioni più preziose del paese, a partire da quella più amata, la Presidenza della Repubblica». Unanime sul documento Prodi cambia anche la qualità dell’opposizione. Accresce la propria forza d’urto contro lo stravolgimento della carta fondamentale dei diritti e dei doveri avendo essa compreso che dalla dissoluzione dell’unità nazionale, dalla limitazione delle istituzioni di garanzia, dalla fine del pluralismo dell’informazione radiotelevisiva è il ruolo dell’opposizione stessa ad essere mortificato e compresso.
Ma è dalla reazione rabbiosa e insultante della maggioranza che meglio si capisce quanto Prodi abbia colto nel segno. Lo stanno accusando di tutto, perfino di essere un «tupamaro» (Vito), di alimentare la «violenza» (Volontè) mentre l’equilibrato Follini gli mette addosso il «passamontagna» alludendo forse alle Br. Che simili farneticazioni giungano proprio dai cosiddetti moderati del Polo la dice lunga sulla vera natura degli Harry Potter del centro, tutti casa (delle libertà) e chiesa.
Pettinati e infiocchettati quando si tratta di indossare la maschera dei berluscones saggi e per bene. Sempre disposti, su ordine del capo, a votare tutte le leggi Previti di questo mondo, a digerire, per opportunismo, qualsiasi negazione delle regole democratiche venga loro propinata.
La denuncia di Prodi serve poi a demistificare, una volta per tutte, la leggenda metropolitana dell’intesa obbligatoria tra i poli. Accordo che in un qualunque sistema bipolare, quindi di fisiologica contrapposizione, diventa possibile, e auspicabile, davanti a questioni vitali per la difesa dello Stato, come per esempio la lotta al terrorismo o le grandi scelte di politica internazionale. Su tutto il resto, fermo restando che la dialettica anche aspra tra maggioranza e opposizione rimane la via maestra di una democrazia sana, il compromesso può starci. Purché sia veramente compromesso, e cioé accordo raggiunto con reciproche concessioni, e non cedimento di una parte alla tracotanza dell’altra parte.
Prendiamo il ruolo dell’Italia nella vicenda irachena. Prendiamo l’ultimo drammatico segmento di questa storia che coincide con l’uccisione di Nicola Calipari e la liberazione di Giuliana Sgrena. Poche ore dopo la sparatoria sulla strada per l’aeroporto di Baghdad, l’Unità ha riconosciuto l’impegno profuso dal governo italiano per arrivare al rilascio della giornalista del manifesto. L’atteggiamento tenuto dal presidente del Consiglio subito dopo quei tragici accadimenti, con l’immediata convocazione a palazzo Chigi dell’ambasciatore americano, ci ha fatto scrivere che, almeno per una volta, Berlusconi si era comportato da statista. Il clima di condivisione ha fatto sì che il successivo dibattito parlamentare fosse improntato al riconoscimento reciproco: avere agito tutti con senso di responsabilità. Subito, il coordinatore di Forza Italia Sandro Bondi propone «una strategia concordata sul futuro dell’Iraq, a prescindere dal giudizio iniziale sulla guerra».
Aggiunge che la prima occasione può essere il voto sul rifinanziamento della missione italiana, lunedì prossimo alla Camera. Davvero una bella «strategia concordata» quella proposta da Bondi: il centrosinistra vota a favore (o si astiene) sulla missione italiana in Iraq e, in cambio, rinuncia a porre la questione della guerra sbagliata (magari affermando che si è trattato di una guerra giusta visto che ha portato il paese alle elezioni anche se era stata dichiarata per trovare le armi di distruzione di massa). Già che ci si trova l’opposizione potrebbe fare qualcosa di più. Ammettere finalmente che quella dei nostri soldati è una missione di pace in un paese in guerra (è una bugia, un controsenso ma è servito ad aggirare la Costituzione vigente che ripudia la guerra come mezzo di offesa o di risoluzione della controversie internazionali). Oppure, un’opposizione, realmente costruttiva e concorde, potrebbe smettere di domandarsi cosa ci stanno a fare i soldati italiani in Iraq, trincerati da mesi nel deserto di Nassiryia.
E se, infine, volesse dare un segno veramente tangibile del nuovo spirito bipartisan l’opposizione potrebbe partecipare al massacro di Giuliana Sgrena, sostenere (come fanno gli esponenti e i giornali della maggioranza) che è lei (e non la guerra sbagliata) la vera causa dell’uccisione di Nicola Calipari.
Certo che il governo Berlusconi si sgancerà dalla guerra sbagliata. Ma lo farà a tempo debito, magari alla vigilia delle prossime elezioni politiche quando vorrà andare all’incasso completo dell’operazione per poter dire agli italiani: vedete come siamo stati bravi, fedeli all’alleanza con gli Usa e, nello stesso tempo, premurosi con i nostri ragazzi? Mentre l’opposizione, se non si sarà piegata, se non avrà chiesto scusa, sarà indicata come antiamericana, antipatriottica, comunista. Proprio come sta accadendo a Romano Prodi, paragonato a un terrorista soltanto perché pretende il rispetto della democrazia.
da l'Unità del 12/03/2005
venerdì 11 marzo 2005
O ti pieghi oppure ti spezzo
giovedì 10 marzo 2005
Il professore e il cardinale
di EDMONDO BERSELLI
A dispetto delle parole trattenute, delle dichiarazioni sotto controllo, delle prudenze e delle alchimie, il duello è cominciato. Romano e il Cardinale. Il professor Prodi e sua eminenza Camillo Ruini. Il candidato del centrosinistra e il presidente della Conferenza episcopale. Non è una baruffa: è un confronto tesissimo, su cui possono incrinarsi gli equilibri nell'Unione e dentro il suo nucleo propulsore, la Federazione ulivista. Possono mischiarsi le posizioni fra destra e sinistra. Possono entrare in crisi rapporti costruiti con dispendio di tempo e di fatica.
Quella che non si consumerà è la rottura fra Ruini e Prodi: ma solo perché si è già consumata da tempo.
Sono passati 35 anni da quando "don Camillo" celebrò il matrimonio di Prodi con Flavia Franzoni. Ruini era uno studioso finissimo, attento alla teologia e alla "teologia politica" tedesca; "Romano" era l'enfant prodige del cattolicesimo emiliano. Adesso il Cardinale è il pastore che si fa imprenditore politico, che rivolge ai cattolici l'appello a disertare il referendum sulla fecondazione assistita. Prodi è un leader politico che dice "sono un cattolico adulto e vado a votare": e quell'"adulto" segna il massimo distacco fra il presidente della Cei e il candidato cattolico del centrosinistra.
E' il caso di ricordare che Ruini era legatissimo alla Democrazia cristiana. Anche nei giorni della disperazione politica, allorché Mino Martinazzoli tentava di reincarnare il corpaccione democristiano nel Partito popolare, il Cardinale non esitò a spendersi, ripetendo che la Dc "non aveva tradito il suo ruolo", e che l'"unità politica" restava un valore o un rimpianto.
Per questa ragione, per il legame con quell'idea di centro moderato, di interclassismo che incorporava statutariamente la dottrina sociale della chiesa, Ruini non accettò di buon grado la dislocazione a sinistra del Professore. Per lui Prodi era più o meno la maschera dei comunisti; e la caduta del suo governo nell'ottobre del 1998 fu presa quasi come un'operazione verità, cioè come la prova che il giudizio era azzeccato. Gratta Prodi e trovi D'Alema, avrebbe potuto dire il don Camillo di Guareschi, e Ruini avrebbe sottoscritto con il più compiaciuto dei suoi lievissimi sorrisi.
"Adulto". E' un aggettivo che per Prodi implica la libertà di giudizio, la maturità democratica, la coscienza che la prova della propria fede si osserva nelle opere, non nei proclami. Nella tessitura degli atti di governo, non nelle parole né tantomeno nei toni o nei sottintesi da crociata.
E' un azzardo, quello di Prodi? Sì, è un azzardo. Ma è un rischio attenuato da alcune convinzioni. In primo luogo da un criterio di laicità intesa, più ancora che come valore, come istinto, come propensione pragmatica, per cui la politica deve andare con un passo diverso da quello dell'appartenenza religiosa.
Forse, in quel dichiararsi "adulto" del cattolico Prodi si può perfino avvertire il riflesso della visione "luterana" del suo maestro, Nino Andreatta: un uomo che non avrebbe mai rinunciato a una battaglia politica, nemmeno se segnata a priori dal crisma della sconfitta.
Ma la vera certezza di Prodi, ancorché inconfessata, è una convinzione di tipo politico. L'assunto di fondo è che la bioetica è una questione troppo seria per lasciarla al "calcolo del consenso"; ma subito dopo c'è anche la sicurezza che la scommessa di Ruini non equivale alla mobilitazione di tutta la chiesa. Il Cardinale infatti ha radicalizzato il confronto, giocando sul referendum buona parte del suo prestigio: eppure non tutti, nelle sfere ecclesiastiche, sono convinti di una scelta che i critici più spregiudicati definiscono, mutati mutandis, "fanfaniana", risvegliando così echi infausti.
E c'è un elemento ulteriore, e forse ancora più rilevante, che Prodi comunque considera cruciale: ossia la divaricazione, che fu esplicita alle elezioni del 1996, tra i vertici della chiesa e la base cattolica. Con la gerarchia vaticana e la Cei che guardavano all'esperienza dell'Ulivo come a una serie di "affrettate semplificazioni", mostrando sospetto e insofferenza. Mentre dal basso, il cattolicesimo dei movimenti, il volontariato, le associazioni, gli assistenti dei gruppi giovanili espressero una larga fiducia verso il progetto prodiano di opposizione al berlusconismo, e di apprezzamento per un progetto di "modernizzazione senza fratture", rispettosa degli equilibri sociali.
Evidentemente Prodi è ancora convinto che sia questo lo schema di fondo che presiede al confronto politico di qui alle elezioni politiche del 2006. Il cattolicesimo del leader dell'Unione fa i conti con il grado di secolarizzazione del Paese, non ignora la varietà delle culture presenti nel centrosinistra. Sa benissimo che il progetto ulivista, e il suo strumento tecnico-politico, ossia la Federazione, contiene anche quegli elementi di forzatura che in questi giorni vengono indicati da alcuni esponenti del popolarismo cristiano (vedi Gerardo Bianco) come il sintomo di un'operazione frettolosa se non incoerente.
Mentre il Cardinale offre una risposta unilaterale, paragonabile per qualcuno al non expedit, Prodi tenta di offrire una risposta istituzionale. Ruini sa che i cattolici di nome e di fatto nella società italiana contemporanea sono una minoranza: ma prova a massimizzare il risultato che questa minoranza può ottenere, agitando un tema altissimo e controverso, la vita umana, a protezione di una legge rudimentale. Tenta di fare entrare nel senso comune, perfino nell'inerzia comportamentale dei cittadini, ossia nella disaffezione elettorale, la visione più esclusiva e gelosa del magistero religioso.
A quanto si capisce, "Romano" non crede alle ipotesi secondo cui sono al lavoro nel centrosinistra anime sante e machiavelliche che progettano il "partito di Ruini": ci sono già troppe forze a destra che speculano su una proclamata fedeltà alla chiesa. Prodi si affida con maggiore fiducia al funzionamento e alla logica istituzionale della democrazia, senza agitare vessilli o illusioni. Sarebbe sbagliato dire che il suo e quello del Cardinale sono due modi di interpretare il cattolicesimo. Ma non è sbagliato affatto giudicare che si tratta di due modi alternativi, cioè sostanzialmente inconciliabili, di interpretare la politica.
(10 marzo 2005)
http://www.repubblica.it/2005/c/sezioni/politica/regionalics/profcard/profcard.html
lunedì 7 marzo 2005
La mia verità
di GIULIANA SGRENA
Sto ancora nel buio. E' stata quella di venerdì la giornata più drammatica della mia vita. Erano tanti i giorni che ero stata sequestrata. Avevo parlato solo poco prima con i miei rapitori, da giorni dicevano che mi avrebbero liberato. Vivevo così ore di attesa. Parlavano di cose delle quali soltanto dopo avrei capito l'importanza. Dicevano di problemi «legati ai trasferimenti». Avevo imparato a capire che aria tirava dall'atteggiamento delle mie due «sentinelle», i due personaggi che mi avevano ogni giorno in custodia. Uno in particolare che mostrava attenzione ad ogni mio desiderio, era incredibilmente baldanzoso. Per capire davvero quello che stava succedendo gli ho provocatoriamente chiesto se era contento perché me ne andavo oppure perché restavo. Sono rimasta stupita e contenta quando, era la prima volta che accadeva, mi ha detto «so solo che te ne andrai, ma non so quando». A conferma che qualcosa di nuovo stava avvenendo a un certo punto sono venuti tutti e due nella stanza come a confortarmi e a scherzare: «Complimenti - mi hanno detto - stai partendo per Roma». Per Roma, hanno detto proprio così.
Ho provato una strana sensazione. Perché quella parola ha evocato subito la liberazione ma ha anche proiettato dentro di me un vuoto. Ho capito che era il momento più difficile di tutto il rapimento e che se tutto quello che avevo vissuto finora era «certo» ora si apriva un baratro di incertezze, una più pesante dell'altra. Mi sono cambiata d'abito. Loro sono tornati: «Ti accompagniamo noi, e non dare segnali della tua presenza insieme a noi sennò gli americani possono intervenire». Era la conferma che non avrei voluto sentire. Era il momento più felice e insieme il più pericoloso. Se incontravamo qualcuno, vale a dire dei militari americani, ci sarebbe stato uno scontro a fuoco, i miei rapitori erano pronti e avrebbero risposto. Dovevo avere gli occhi coperti. Già mi abituavo ad una momentanea cecità. Di quel che accadeva fuori sapevo solo che a Baghdad aveva piovuto. La macchina camminava sicura in una zona di pantani. C'era l'autista più i soliti due sequestratori. Ho subito sentito qualcosa che non avrei voluto sentire. Un elicottero che sorvolava a bassa quota proprio la zona dove noi ci eravamo fermati. «Stai tranquilla, ora ti verranno a cercare...tra dieci minuti ti verranno a cercare». Avevano parlato per tutto il tempo sempre in arabo, e un po' in francese e molto in un inglese stentato. Anche stavolta parlavano così.
Poi sono scesi. Sono rimasta in quella condizione di immobilità e cecità. Avevo gli occhi imbottiti di cotone, coperti da occhiali da sole. Ero ferma. Ho pensato...che faccio? comincio a contare i secondi che passano da qui ad un'altra condizione, quella della libertà? Ho appena accennato mentalmente ad una conta che mi è arrivata subito una voce amica alle orecchie: «Giuliana, Giuliana sono Nicola, non ti preoccupare ho parlato con Gabriele Polo, stai tranquilla sei libera».
Mi ha fatto togliere la «benda» di cotone e gli occhiali neri. Ho provato sollievo, non per quello che accadeva e che non capivo, ma per le parole di questo «Nicola». Parlava, parlava, era incontenibile, una valanga di frasi amiche, di battute. Ho provato finalmente una consolazione quasi fisica, calorosa, che avevo dimenticato da tempo. La macchina continuava la sua strada, attraversando un sottopassaggio pieno di pozzanghere, e quasi sbandando per evitarle. Abbiamo tutti incredibilmente riso. Era liberatorio. Sbandare in una strada colma d'acqua a Baghdad e magari fare un brutto incidente stradale dopo tutto quello che avevo passato era davvero non raccontabile. Nicola Calipari allora si è seduto al mio fianco. L'autista aveva per due volte comunicato in ambasciata e in Italia che noi eravamo diretti verso l'aeroporto che io sapevo supercontrollato dalle truppe americane, mancava meno di un chilometro mi hanno detto...quando...Io ricordo solo fuoco. A quel punto una pioggia di fuoco e proiettili si è abbattuta su di noi zittendo per sempre le voci divertite di pochi minuti prima.
L'autista ha cominciato a gridare che eravamo italiani, «siamo italiani, siamo italiani...», Nicola Calipari si è buttato su di me per proteggermi, e subito, ripeto subito, ho sentito l'ultimo respiro di lui che mi moriva addosso. Devo aver provato dolore fisico, non sapevo perché. Ma ho avuto una folgorazione, la mia mente è andata subito alle parole che i rapitori mi avevano detto. Loro dichiaravano di sentirsi fino in fondo impegnati a liberarmi, però dovevo stare attenta «perché ci sono gli americani che non vogliono che tu torni». Allora, quando me l'avevano detto, avevo giudicato quelle parole come superflue e ideologiche. In quel momento per me rischiavano di acquistare il sapore della più amara delle verità.
Il resto non lo posso ancora raccontare.
Questo è stato il giorno più drammatico. Ma il mese che ho vissuto da sequestrata ha probabilmente cambiato per sempre la mia esistenza. Un mese da sola con me stessa, prigioniera delle mie convinzioni più profonde. Ogni ora è stata una verifica impietosa sul mio lavoro. A volte mi prendevano in giro, arrivavano a chiedermi perché mai volessi andar via, di restare. Insistevano sui rapporti personali. Erano loro a farmi pensare a quella priorità che troppo spesso mettiamo in disparte. Puntavano sulla famiglia. «Chiedi aiuto a tuo marito», dicevano. E l'ho detto anche nel primo video che credo avete visto tutti. La vita mi è cambiata. Me lo raccontava l'ingegnere iracheno Ra'ad Ali Abdulaziz di "Un Ponte per" rapito con le due Simone, «la mia vita non è più la stessa», diceva. Non capivo. Ora so quello che voleva dire. Perché ho provato tutta la durezza della verità, la sua difficile proponibilità. E la fragilità di chi la tenta.
Nei primi giorni del rapimento non ho versato una sola lacrima. Ero semplicemente infuriata. Dicevo in faccia ai miei rapitori: «Ma come, rapite me che sono contro la guerra?!». E a quel punto loro aprivano un dialogo feroce. «Sì, perché tu vai a parlare con la gente, non rapiremmo mai un giornalista che se ne sta chiuso in albergo. E poi il fatto che dici di essere contro la guerra potrebbe essere una copertura». E io ribattevo, quasi a provocarli: «E' facile rapire una donna debole come me, perché non provate con i militari americani?». Insistevo sul fatto che non potevano chiedere al governo italiano di ritirare le truppe, il loro interlocutore «politico» non poteva essere il governo ma il popolo italiano che era ed è contro la guerra.
E' stato un mese di altalena, tra speranze forti e momenti di grande depressione. Come quando, era la prima domenica dopo il venerdì del rapimento, nella casa di Baghdad dove ero sequestrata e su cui svettava una parabolica, mi fecero vedere un telegiornale di Euronews. Lì ho visto la mia foto in gigantografia appesa al palazzo del comune di Roma. E mi sono rincuorata. Poi però, subito dopo, è arrivata la rivendicazione della Jihad che annunciava la mia esecuzione se l'Italia non avesse ritirato le sue truppe. Ero terrorizzata. Ma subito mi hanno rassicurata che non erano loro, dovevo diffidare di quei proclami, erano dei «provocatori». Spesso chiedevo a quello che, dalla faccia, sembrava il più disponibile che comunque aveva, con l'altro, un aspetto da soldato: «Dimmi la verità, mi volete uccidere». Eppure, molte volte, c'erano strane finestre di comunicazione, proprio con loro. «Vieni a vedere un film in tv», mi dicevano, mentre una donna wahabita, coperta dalla testa ai piedi girava per casa e mi accudiva.
I rapitori mi sono sembrati un gruppo molto religioso, in continua preghiera sui versetti del Corano. Ma venerdì, al momento del mio rilascio, quello tra tutti che sembrava il più religioso e che ogni mattina si alzava alla 5 per pregare, mi ha fatto le sue «congratulazioni» incredibilmente stringendomi fortemente la mano - non è un comportamento usuale per un fondamentalista islamico -, aggiungendo «se ti comporti bene parti subito». Poi, un episodio quasi divertente. Uno dei due guardiani è venuto da me esterrefatto sia perché la tv mostrava i miei ritratti appesi nelle città europee e sia per Totti. Sì Totti, lui si è dichiarato tifoso della Roma ed era rimasto sconcertato che il suo giocatore preferito fosse sceso in campo con la scritta «Liberate Giuliana» sulla sua maglietta.
Ho vissuto in una enclave in cui non avevo più certezze. Mi sono ritrovata profondamente debole. Avevo fallito nelle mie certezze. Io sostenevo che bisognava andare a raccontare quella guerra sporca. E mi ritrovavo nell'alternativa o di stare in albergo ad aspettare o di finire sequestrata per colpa del mio lavoro. «Noi non vogliamo più nessuno», mi dicevano i sequestratori. Ma io volevo raccontare il bagno di sangue di Falluja dalle parole dei profughi. E quella mattina già i profughi, o qualche loro «leader» non mi ascoltavano. Io avevo davanti a me la verifica puntuale delle analisi su quello che la società irachena è diventata con la guerra e loro mi sbattevano in faccia la loro verità: «Non vogliamo nessuno, perché non ve ne state a casa, che cosa ci può servire a noi questa intervista?». L'effetto collaterale peggiore, la guerra che uccide la comunicazione, mi precipitava addosso. A me che ho rischiato tutto, sfidando il governo italiano che non voleva che i giornalisti potessero raggiungere l'Iraq, e gli americani che non vogliono che il nostro lavoro testimoni che cosa è diventato quel paese davvero con la guerra e nonostante quelle che chiamano elezioni.
Ora mi chiedo. E' un fallimento questo loro rifiuto?
da Il manifesto del 6/3/2005
Maledette siano le guerre e le canaglie che le fanno
di LUIS SEPÚLVEDA
Maledette siano le guerre e le canaglie che le fanno, disse Julio Anguita, un dirigente storico della sinistra spagnola, quando seppe che suo figlio, il giornalista Julio Anguita Parrando, era morto in Iraq per gli spari dell'esercito americano - o «fuoco amico», come cercarono di spiegare i difensori di quella guerra basata sulle menzogne e sulle ambizioni dei gruppi economici più forti negli Stati uniti. Più tardi un altro giornalista spagnolo, José Couso, ha potuto vedere come un carrarmato statunitense puntava verso il balcone dell'hotel in cui si trovava. Anche lui è morto «sotto il fuoco amico», perché così ha concluso la parodia di indagine svolta dall'esercito americano e pienamente accettata dal governo di ultradestra di José Maria Aznar.
Troppi giornalisti sono morti o sono stati feriti in Iraq. Troppi iracheni - oltre centomila, 100.000! sono caduti sotto i proiettili delle forze d'occupazione e le bombe intelligenti, vittime della «morale di guerra» sbandierata da criminali come il generale Jim Mattis, capo dei marines che hanno devastato Falluja e uomo temprato in Afghanistan. Alcuni ricordano le immagini dei resti umani di varie persone che assistevano a un matrimonio in Afghanistan e furono bombardati dagli americani. «C'era gente in età militare», aveva giustificato il generale Mattis. E, interrogato dalla televisione Fox su cosa sentisse a Falluja, aveva detto «sparare alla gente è eccitante».
Dobbiamo stupirci che Giuliana Sgrena stia - per fortuna - riprendendosi dalle ferite ricevute a 700 metri dall'aereoporto di Baghdad, quando il veicolo su cui viaggiava aveva già passato diversi controlli?
Che spiegazione daranno gli Stati uniti al governo italiano, altra forza occupante dell'Iraq che ha perso già troppi uomini, troppi italiani tornati avvolti nei sacchi di plastica?
Berlusconi avrà la faccia tosta di dire alla famiglia di Nicola Calipari e degli altri italiani feriti che sono stati raggiunti da «fuoco amico»?
In Europa sappiamo che la manipolazione del «patriottismo» conduce su strade oscure, senza altra via d'uscita che avanzare verso l'abisso, e che sebbene Mussolini e Hitler avessero il favore di maggioranze accecate da un osceno patriottismo nulla giustifica i crimini che hanno commesso. Allo stesso modo, il trionfo di George W. Bush alle ultime elezioni statunitensi non giustifica né la guerra in Iraq, né l'occupazione di questo paese, né l'atroce campagna di minacce contro l'Iran e la Siria intrapresa dal duo Bush-Rice. Ogni giorno di permanenza delle forze militari europee in Iraq è un atto di vassallaggio e di complicità, più che con una nazione potente con un gruppo di esaltatori dell'imperialismo - Bush, Rumsfeld, Wolfowitz, Cheney, Rice - che pretende di imporre un'idea messianica dell'ordine internazionale, ma un ordine basato sulla forza e l'aggressione imperialista.
E' possibile che i soldati statunitensi che hanno sparato contro il veicolo che conduceva Giuliana Sgrena, che hanno ucciso Nicola Calipari e ferito altri due agenti italiani, non sapessero neppure contro chi sparavano: perché la maggioranza degli americani finiti in Iraq sono poveri diavoli reclutati tra gli emigranti ispanici - per lo più centroamericani - che hanno accettato di vestire l'uniforme yankee e partecipare a una guerra che non capiscono, in un paese di cui ignorano tutto, in cambio della nazionalità statunitense, portuma nella gran parte dei casi.
Quello che però risulta inconcepibile e impossibile da accettare è la tesi che il veicolo «andava troppo veloce» e che «non ha obbedito all'ordine di fermarsi». Con oltre millecinquecento caduti, le forze di occupazione hanno un perimetro di sicurezza piuttosto rigoroso attorno all'aereoporto, secondo le dichiarazioni della stessa Giuliana Sgrena: e loro erano già passati per altri controlli, e oltretutto nessuno può credere o accettare che tra le forze occupanti esista una tale mancanza di coordinazione tra le informazioni e che i soldati americani ignorassero che quel veicolo portava una giornalista appena liberata da un mese di sequestro.
Cara Giuliana, benvenuta in Italia, dai tuoi. Tutta la mia solidarietà alle famiglie di Nicola Callipari e degli agenti feriti, e pensando ai caduti, che sono troppi, soprattutto i morti della popolazione civile irachena, una riflessione oggi più necessaria che mai: maledette siano le guerre e le canaglie che le fanno.
da il manifesto del 6/3/2005